di Leonardo Mazzei da sinistrainrete.info
L’invocazione del direttore del Sole 24 Ore al fantasmatico ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan
 Che nei piani alti del potere economico vi fosse una certa maretta si sapeva. Adesso però le acque si fanno agitate, e dalla maretta sembra che si stia per passare ai marosi.
Che nei piani alti del potere economico vi fosse una certa maretta si sapeva. Adesso però le acque si fanno agitate, e dalla maretta sembra che si stia per passare ai marosi.
Il 30 dicembre scorso il direttore del quotidiano di Confindustria, Roberto Napoletano, ha deciso di mandare di traverso il cenone di San Silvestro di Pier Carlo Padoan. Dopo averlo ospitato, due giorni prima, nell’accogliente sede del giornale per un’intervista di ben 3 pagine, Napoletano ha deciso di dirla tutta: se veramente esistete (come governo), se davvero esisti (come ministro dell’Economia) cosa aspetti (e/o aspettate) a darcene prova?
Prima di dedicarci al merito del grido d’allarme di Napoletano, facciamo un passo indietro per dare uno sguardo all’intervista di Padoan. Tre pagine abbiamo detto, ma tre pagine di assoluta banalità. Gli altri media che se ne sono occupati hanno messo in rilievo il riferimento del ministro all’«opacità» della decisione della Bce su Mps. Sai che coraggio!
Il bello, poi, è che questa denuncia di opacità è preceduta da mille rassicurazioni sul fatto che il governo italiano nulla farà per reagire all’affronto subito. All’intervistatore che gli chiede se vi sia intenzione di contestare formalmente la richiesta di ricapitalizzazione giunta da Francoforte, così inizia la risposta di Padoan:
«La richiesta di 8,8 miliardi per l’aumento di capitale di Monte dei Paschi è una decisione votata dal board della vigilanza della Bce, anche se a maggioranza e non all’unanimità, e come tale non è contestabile perché la vigilanza è un’autorità indipendente».
Avete capito? La «Vigilanza» è un’autorità «indipendente», ed il Supervisory board decide a piacimento, in maniera «indipendente» perfino dai vertici della Bce, figuriamoci da quelli dell’UE, per non parlare dei governi nazionali! Ora, se davvero così fosse, non sarebbe questa la riprova dell’assoluta antidemocraticità delle istituzioni di un’Unione messa in mano ad una tecnocrazia che nessuno controlla? Ma così non è. Le cose infatti sono messe ancora peggio. Questa tecnocrazia esiste, ma a qualcuno risponde, come dimostra l’assoluta assonanza delle sue decisioni – nel caso prettamente politiche, come abbiamo già scritto – con i padroni tedeschi dell’Europa.
In quanto allo spessore mostrato da Padoan, citiamo altre due affermazioni da incorniciare. Alla contestazione del ritardo con il quale si è deciso di nazionalizzare Mps, così risponde:
«Non sono affatto pentito di aver sostenuto, nel rispetto dei ruoli di tutti, l’operazione di mercato, che sarebbe stata l’opzione migliore e avrebbe avuto effetti positivi, evitando i problemi che invece vanno gestiti adesso».
Insomma: mercato! mercato! mercato! Ma con quale faccia? E’ proprio vero che «ad andar con gli zoppi si impara a zoppicare», ed a forza di sentire le balle di Renzi costui ha finito per crederci. Ma perché l’«operazione di mercato» è fallita? Questo il ministro non ce lo dice. Ci dice anzi che dalle parti di Siena tutto va bene, Madama la Marchesa. Leggere per credere questa seconda affermazione di Padoan:
«Vorrei cogliere questa occasione per ringraziare il management del Monte dei Paschi che ha fatto un gran lavoro. La banca è in ottime condizioni e avrà grande successo».
Roba da far strabuzzare gli occhi, e dalle parti di Confindustria devono aver fatto due conti sulla carta e l’inchiostro sprecato nell’occasione.
Ecco allora il deciso editoriale di Roberto Napoletano, cortese nella forma col ministro, quanto fermo nella richiesta di un’azione che evidentemente si valuta non ci sia. Ovviamente quest’azione non c’è, semplicemente perché non può esservi senza la messa in discussione della gabbia europea. Su questo, ovviamente, anche il direttore del Sole tace. Tuttavia, gli argomenti che egli tocca mettono in luce come nel campo dei dominanti – al di là della solita retorica europeista e mercatista – vi sia ormai la vera percezione della posta in gioco.
Passiamo dunque a quanto scritto da Napoletano.
L’incipit è folgorante:
«Le sofferenze sono diventate lo stigma del banking europeo e dietro di esse ci sono le chiavi di potere di un club della finanza internazionale dove tedeschi e francesi comandano, gli spagnoli si “aggiustano”, e gli italiani pagano il conto di tutti».
L’accusa non è nuova, ed è più che fondata: l’asse carolingio che comanda in Europa concentra tutte le sue attenzioni sulle sofferenze (e dunque sull’Italia), mentre chiude entrambi gli occhi sui titoli potenzialmente tossici in pancia alle banche francesi e tedesche, non solo allo scopo di proteggere queste ultime, ma anche con il fine ultimo di fargli mettere le mani sulle banche italiane, all’uopo indebolite ben bene dalla sistematica azione delle istituzioni di Bruxelles e Francoforte.
Insomma, come andiamo dicendo da tempo, c’è del metodo nella follia europea.
Napoletano questo lo dice con chiarezza. E, certamente memore del gran numero di acquisizioni francesi in Italia di questi ultimi tempi, non si limita alle sole banche:
«Questa è l’Europa che la politica italiana non può più accettare perché alla fine di tale circolo vizioso lo scenario più probabile è che le banche francesi si comprino quelle italiane, finanzino, ben pagando, l’acquisto del Made in Italy e, magari, mobilitando unitariamente il sistema francese, fatto di credito, compagnie assicurative, tecnocrati e politica, arrivino a stringere il collo anche alle Generali».
Ed ancora: «
Francesi, tedeschi, spagnoli non possono dare lezioni a nessuno, ed è troppo comodo (oltre che immorale) fare in modo che il mondo si occupi solo di noi, si deprezzi il patrimonio finanziario e industriale italiano e, per questa via, fare sì che i “padroni” del club europeo ci comprino a prezzi di saldo».
Lo scenario descritto dal direttore del quotidiano di Confindustria è quello di cui abbiamo parlato tante volte. E sapevamo che quando si sarebbe trattato anche dei loro soldi e dei loro beni, dunque non più soltanto del valore delle pensioni e di quello dei salari, dell’occupazione e dello stato sociale, pure lorsignori avrebbero avuto qualcosa da ridire.
Bene, siamo arrivati a questo punto. Il che, detto di passaggio, ci dimostra quanto i tempi del redde rationem si siano fatti ormai molto stretti.
Stretti da richiedere una sorta di implorazione.
«Lo ascolto (Padoan, ndr) e penso che dice cose che hanno fondamento ma mi domando che cosa aspetta a prendere l’iniziativa politica per rimettere in discussione un sistema europeo di sostenibilità del business bancario e di vigilanza fondato su basi malferme…».
Così inizia l’invocazione di Napoletano. Ma più avanti la sua supplica diventa avvertimento:
«Gentiloni e Padoan sono avvertiti, lascino che il Parlamento si occupi di fare qualcosa che assomigli a una legge elettorale, ma se vogliono dare una ragione vera di esistenza al loro governo si occupino della questione bancaria europea e dimostrino di contare qualcosa dove si prendono le decisioni».
Il tono è di chi è avvezzo a dare ordini. Il fatto è che il duo Gentiloni-Padoan ha anche altri padroni a cui obbedire. Facendo di nuovo un passo indietro all’intervista di Padoan, significativo è questo scambio: «C’è troppa Francia in Italia?», chiede Napoletano. Risposta illuminante del ministro: «Non so se c’è troppa Francia, forse non c’è ancora abbastanza Italia nel mondo». Insomma, alla concretezza del primo, il secondo risponde con una piatta riproposizione dell’ideologia globalista alla quale però non sembrano più credere in molti.
Ma Napoletano non si limita ad avvisare il governo. Il suo avvertimento è rivolto anche ai partiti, Quantomeno quelli tradizionali. Un tema che merita un’ultima citazione:
«I partiti, quelli tradizionali, continuano ad occuparsi di distribuzione del potere, ma non si accorgono che quel potere è diventato un guscio vuoto, lottano tra di loro ma non avranno nulla in mano e perdono il contatto con l’anima popolare del Paese e il disagio sociale che lo attraversa. Non si occupano del rischio di essere tutti travolti dal “superpotere” tedesco o da quello francese altrettanto presente ma più mimetizzato, e si avviano a fare la fine dei capponi di Renzo di manzoniana memoria che si beccavano tra di loro invece di pensare a salvarsi dalla padella…».
Che dire? Dalle parti di Confindustria almeno certe fotografie le sanno fare come si deve. La descrizione dei partiti come organismi che si occupano ormai soltanto di una sorta di sotto-potere sottostante ai veri padroni, quelli dell’asse carolingio, gli è venuta proprio bene. Peccato che, sempre da quelle parti, lorsignori abbiano a lungo lavorato (per tre decenni, potremmo dire) proprio all’obiettivo di ridurre la politica a mera governance, sottoposta ai dogmi dell’economia ed al primato del mercato. Cioè, detto in altri termini, proprio agli interessi dei datori di lavoro di Roberto Napoletano.
Di nuovo l’eterogenesi dei fini! Hanno tanto lavorato alla distruzione dei partiti e della politica (correttamente intesa), che oggi che hanno raggiunto quel risultato tornerebbero – magari solo “temporaneamente”, come la “nazionalizzazione” di Mps – volentieri indietro!
Vedremo a breve quali effetti sortirà la supplica di fine anno di cui ci siamo occupati. Alla capacità di questo governo di far fronte ai padroni europei ci crediamo come a Babbo Natale. Anzi, quest’ultimo ci sembra tutto sommato più credibile. Più interessante, semmai, cercare di capire quali altre strade verranno allora studiate nei piani alti del potere economico di cui abbiamo parlato all’inizio di questo articolo.
Quel che è certo è che i temi che mettiamo ormai da tanto tempo al centro dei nostri ragionamenti – la gabbia europea e quella della moneta unica, gli interessi che la guidano, l’impossibilità per il nostro Paese di venir fuori dalla crisi senza uscire da queste gabbie, la necessità di riconquistare la sovranità nazionale anche per non finire sbranati dagli interessi di altre nazioni – trovano una plateale conferma nella trattazione di Napoletano. Trattazione fatta dal versante opposto al nostro, ma proprio per questo interessante. Perché dimostra come la maschera ideologica globalista stia adesso cadendo come uno straccio ormai diventato inservibile anche per lorsignori.
I quali, beninteso, non smettono per un secondo di pensare ai loro sporchi affari, sia quando dicono che i mercati globali sono tutto, sia quando si ricordano di essere italiani. Ma il fatto che oggi qualcuno di loro cominci a prender atto della questione nazionale ci dice pur sempre qualcosa.
Sul punto concludo con quanto scritto da Mimmo Porcaro in un articolo che abbiamo pubblicato ieri. Porcaro, dopo aver affermato che oggi «la politica ricomincia dalla nazione», chiarisce assai bene cosa significa per noi – a differenza delle classi dominanti – il concetto di interesse nazionale. Leggiamo:
«E’ la definizione di un interesse nazionale (che le nostre classi dominanti non a caso non sanno definire, e che per noi coincide con l’interesse delle classi subalterne) a imporci di rompere con l’Unione e a guidarci nella costruzione di nuove relazioni internazionali. Che il 2017 ci dia il coraggio di cominciare ad essere nazione».
E’ proprio l’interesse delle classi subalterne, il bisogno di uscire dall’attuale quadro di oppressione, che richiede ora questo salto di qualità. Ora, non quando sarà troppo tardi.
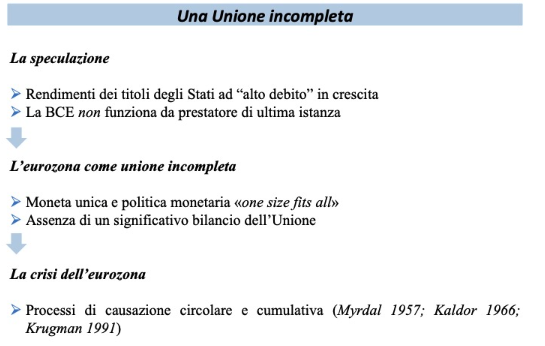

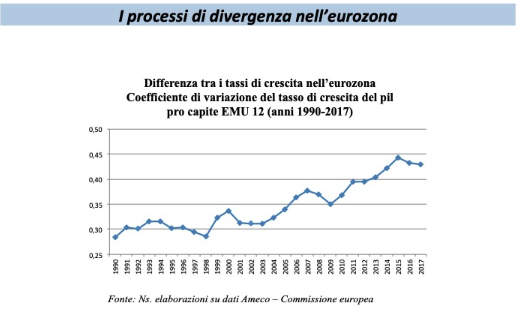
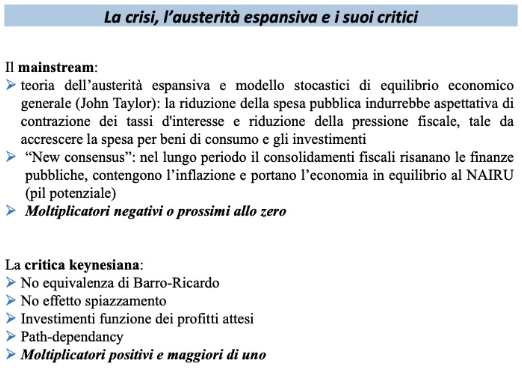
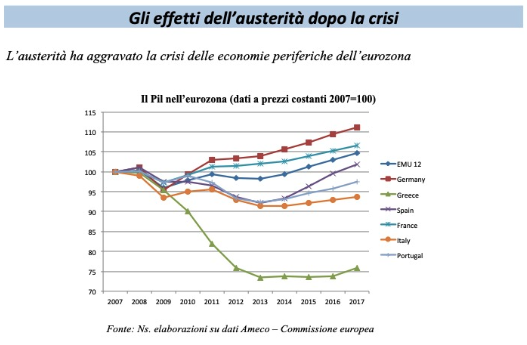
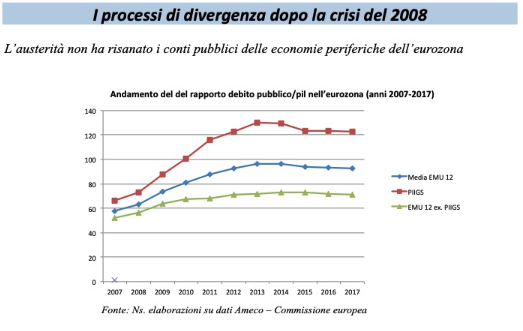
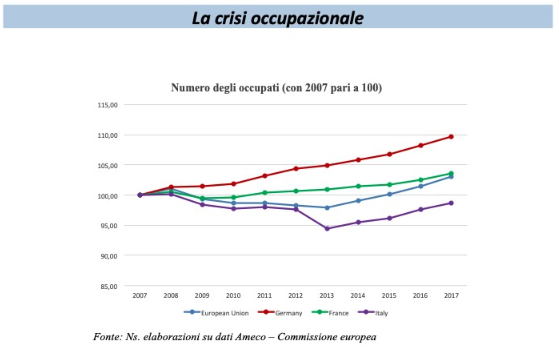


 Che nei piani alti del potere economico vi fosse una certa maretta si sapeva. Adesso però le acque si fanno agitate, e dalla maretta sembra che si stia per passare ai marosi.
Che nei piani alti del potere economico vi fosse una certa maretta si sapeva. Adesso però le acque si fanno agitate, e dalla maretta sembra che si stia per passare ai marosi.